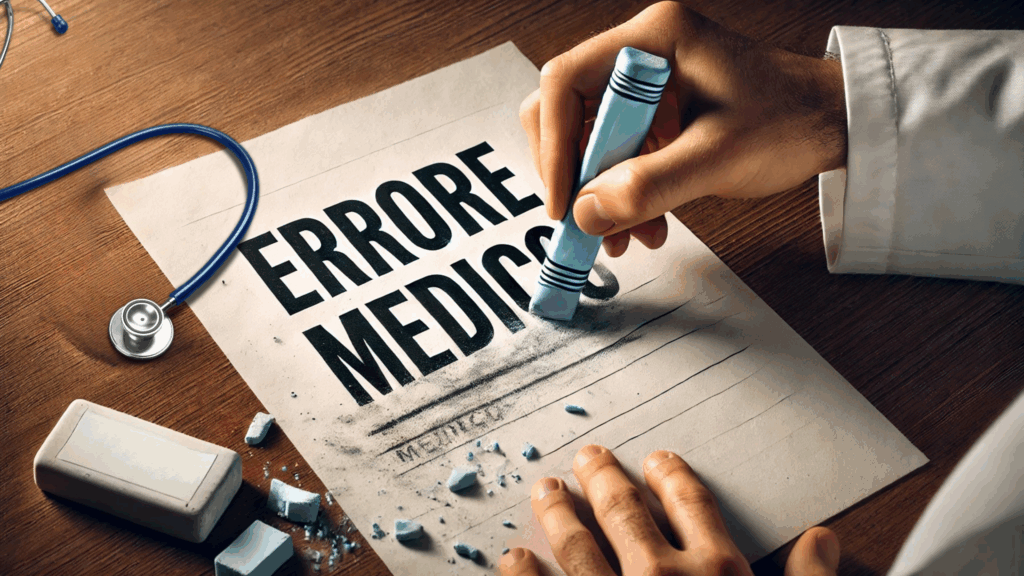La ricerca scientifica conferma: una comunicazione inadeguata su rischi ed errori sanitari compromette la fiducia, aumenta i costi e ostacola il miglioramento. La trasparenza è la vera chiave per la sicurezza delle cure.
Quando non comunicare è peggio che sbagliare
Un errore medico può avere conseguenze drammatiche sulla salute di un paziente. Ma cosa succede quando, oltre all’errore, si aggiunge il silenzio? Quando una struttura sanitaria non comunica, comunica male o nasconde informazioni su rischi, errori o incidenti?
La risposta arriva dalla letteratura scientifica internazionale ed è inequivocabile: una comunicazione scorretta o assente su rischi, errori o incidenti sanitari compromette profondamente la credibilità di una struttura sanitaria e mina la fiducia di pazienti e operatori. Non si tratta solo di un problema etico o relazionale. Le conseguenze di una cattiva comunicazione sono misurabili, concrete e pervasive, con impatti che vanno ben oltre il singolo episodio.
Le conseguenze della mancata trasparenza: cosa dice la scienza
La mancanza di trasparenza e la gestione opaca delle informazioni generano sfiducia sistemica nel servizio sanitario. Come dimostrano Alizadeh et al. (2025) e Smith (2017), quando le strutture sanitarie non comunicano apertamente su errori e rischi, i pazienti perdono fiducia nelle strutture coinvolte, la qualità percepita dei servizi diminuisce drasticamente, aumenta il rischio di comportamenti corruttivi e i costi sanitari complessivi crescono. La fiducia, una volta erosa, è difficilissima da ricostruire. E senza fiducia, l’intero sistema sanitario vacilla.
Schlesinger & Grob (2023) evidenziano come risposte inadeguate agli errori medici moltiplichino l’effetto negativo dell’errore stesso. Ghahramanian et al. (2017) dimostrano che senza trasparenza diventa impossibile valutare accuratamente la qualità dei servizi erogati, identificare le aree di miglioramento prioritarie, implementare correttivi efficaci e monitorare i progressi nel tempo.
Paradossalmente, il tentativo di nascondere gli errori ne favorisce la proliferazione. Keshtkar et al. (2025) e Howick et al. (2024) hanno documentato come la mancanza di comunicazione sugli errori sia essa stessa un fattore di rischio per la ripetizione degli stessi errori in futuro, la diffusione di pratiche non sicure, il mancato apprendimento organizzativo e il deterioramento dei protocolli di sicurezza. Amlaev et al. (2022) confermano quanto diciamo anche noi di Fondazione SANIRE da tempo: gli errori medici sono spesso conseguenza diretta di una comunicazione carente.
Quando la comunicazione è punitiva o assente, si instaura una “cultura del silenzio”. Ghahramanian et al. (2017), Swinfen et al. (2023) e Van Baarle et al. (2022) dimostrano che la paura di essere colpevolizzati riduce drasticamente le segnalazioni: gli operatori sanitari preferiscono tacere piuttosto che esporsi, il sistema perde la possibilità di intercettare i problemi in fase precoce e si perpetua un circolo vizioso di errori non dichiarati.
Le conseguenze psicologiche di una cattiva comunicazione sono profonde e persistenti. Prentice et al. (2020) hanno documentato che i pazienti che non ricevono informazioni chiare su errori o rischi tendono a evitare le strutture coinvolte e sviluppano sentimenti di abbandono, rabbia e tradimento, con effetti emotivi che possono durare anni. Anche il personale sanitario paga un prezzo alto. Olagundoye et al. (2022) evidenziano che la mancanza di feedback dopo incidenti genera stress cronico e burnout, senso di isolamento professionale, perdita di fiducia nella leadership e sfiducia nei processi organizzativi.
Il valore della comunicazione aperta: i benefici della trasparenza
La buona notizia è che esiste un antidoto efficace: la comunicazione aperta e tempestiva. Van Baarle et al. (2022) e Prentice et al. (2020) dimostrano che quando le strutture sanitarie comunicano in modo trasparente si riduce l’impatto emotivo negativo sui pazienti e le famiglie, aumentano le segnalazioni degli errori da parte degli operatori, si promuove una cultura di apprendimento e miglioramento continuo e si favorisce il recupero della fiducia dopo un errore.
La trasparenza, come sottolineano Schlesinger & Grob (2023) e Alizadeh et al. (2025), è fondamentale per ristabilire la fiducia dopo un errore, prevenire l’erosione della credibilità istituzionale, costruire relazioni più mature tra pazienti e operatori e migliorare effettivamente la sicurezza delle cure.
Il caso italiano: la ricerca SANIRE sulla trasparenza
Questi dati internazionali trovano conferma anche in Italia. La Fondazione Sanità Responsabile (SANIRE) si è recentemente occupata proprio del tema della trasparenza in sanità, presentando nel novembre 2024 un’ampia ricerca condotta in collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila. Lo studio, intitolato Rapporto sullo stato di attuazione della legge n. 24 del 2017 – cd. Gelli-Bianco – in tema di sicurezza delle cure e di responsabilità civile delle strutture sanitarie, ha analizzato lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge Gelli-Bianco nelle principali strutture ospedaliere pubbliche italiane, verificando la pubblicazione di dati sui risarcimenti erogati, relazioni annuali sugli eventi avversi e informazioni sulle coperture assicurative.
I risultati confermano quanto emerso dalla letteratura internazionale: la trasparenza in Italia è ancora insufficiente e disomogenea. Quasi la metà delle strutture analizzate non rispetta pienamente gli obblighi normativi, limitando così la possibilità per cittadini e operatori di accedere a informazioni cruciali per valutare la sicurezza delle cure. Come evidenziato durante l’evento di Roma del novembre 2024, questa mancanza di trasparenza non è solo un problema normativo, ma rappresenta un ostacolo concreto al miglioramento del sistema sanitario.
Cosa fare: dalle evidenze scientifiche all’azione
La letteratura scientifica offre indicazioni chiare su cosa funziona. Le strutture sanitarie devono implementare protocolli che prevedano comunicazione tempestiva agli interessati quando si verifica un evento avverso, spiegazioni chiare su cause, conseguenze e misure correttive, e supporto emotivo e pratico a pazienti e familiari coinvolti.
Van Baarle et al. (2022) sottolineano l’importanza di creare una “just culture”, un ambiente in cui gli errori vengono segnalati senza paura di ritorsioni, si distingue tra errori umani inevitabili e negligenza, il focus è sull’apprendimento e non sulla punizione, e la responsabilità è sistemica e non solo individuale.
Gli operatori sanitari devono essere formati specificamente su come comunicare un errore o un evento avverso, come gestire le reazioni emotive di pazienti e familiari, come bilanciare onestà professionale e supporto empatico, e come utilizzare la comunicazione come strumento di cura. A livello istituzionale, è necessario pubblicare regolarmente dati su errori e risarcimenti, rendere le informazioni facilmente accessibili e comprensibili, monitorare l’efficacia delle politiche di comunicazione e condividere le lezioni apprese a livello di sistema.
Comunicare per curare
La conclusione che emerge dalla ricerca scientifica è inequivocabile: comunicare male o non comunicare su rischi, errori e incidenti sanitari è dannoso quanto il silenzio stesso. Una comunicazione aperta e tempestiva riduce l’impatto emotivo negativo sugli utenti, favorisce la segnalazione degli errori e promuove una cultura di apprendimento e miglioramento continuo. La trasparenza è fondamentale per ristabilire la fiducia dopo un errore e per prevenire l’erosione della credibilità istituzionale.
La comunicazione non è un optional né un mero adempimento burocratico. È parte integrante della cura, essenziale per la sicurezza dei pazienti, la soddisfazione degli utenti, il benessere degli operatori, la fiducia nel sistema sanitario e il miglioramento continuo della qualità. In un momento storico in cui il rapporto tra pazienti e sistema sanitario appare sempre più fragile, investire nella comunicazione trasparente non è solo eticamente giusto: è strategicamente indispensabile.
Come ricorda la Fondazione SANIRE nel suo impegno quotidiano per la promozione della cultura della sicurezza delle cure: la trasparenza non è il problema, ma la soluzione. Il silenzio non protegge nessuno. Solo la comunicazione aperta, onesta e tempestiva può costruire le basi per un sistema sanitario più sicuro, più giusto e più umano.